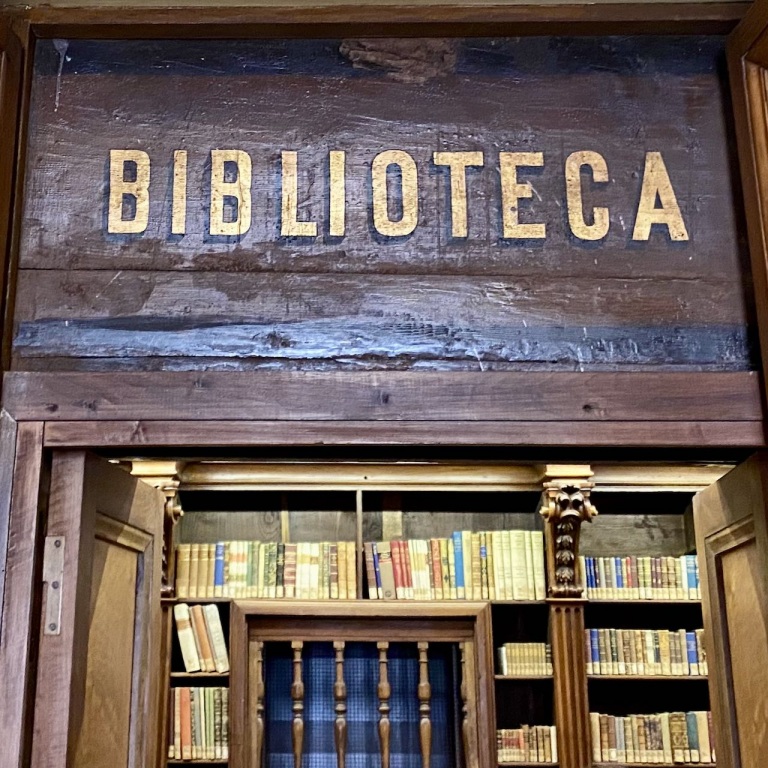L’Italia è il paese democratico che detiene la regolamentazione sulla circolazione dei libri rari più severa dell’Occidente. Non di rado essa è percepita da noi librai antiquari, anche a torto, come un’ingerenza istituzionale esercitata con arbitrio, che mina la nostra libertà d’impresa1. Faccio un solo lungo esempio, che spero indicativo. Nel 2019 la Soprintendenza del Piemonte e della Valle d’Aosta ha notificato – cioè dichiarato di eccezionale interesse nazionale e dunque, innanzitutto, vietato all’esportazione – sette volumi di valore modesto, poche centinaia di euro l’uno, per la presenza sulle loro controguardie dell’Ex libris del bibliofilo milanese Spartaco Asciamprener (1915-1954)2. Il decreto motivava la decisione con «l’elevato interesse della raccolta», che tuttavia da decenni non è più esistente, smembrata e dispersa, senza che nessuno abbia mai espresso pubblicamente la volontà di ricostituirla. Il provvedimento suggeriva inoltre di applicare lo stesso rigore «per ogni altro volume appartenente alla medesima raccolta libraria», tanto che oggi ogni libro con l’Ex libris di Asciamprener presentato agli Uffici Esportazione viene sistematicamente bloccato.
Esemplari di volumi singoli con l’Ex Libris Asciamprener circolano nel mercato antiquario da oltre mezzo secolo, a seguito di vendite effettuate legittimamente dagli eredi in tempi diversi; tuttora è sufficiente una ricerca online per accorgersene. La parte più cospicua dei libri da lì provenienti fu acquisita e rivenduta negli anni Sessanta dal libraio Carlo Alberto Chiesa3. Inoltre, sebbene Spartaco Asciamprener – industriale nel settore vetrario, corridore motociclista, autore di versi e amico dei librai – si fosse prefissato di riunire al Lorenteggio una biblioteca eterogenea pressoché leggendaria, le vicissitudini della guerra e la sua prematura scomparsa a soli 39 anni glielo impedirono, come racconta Cesarino Branduani4. La comunità accademica si è sempre interrogata, tra l’altro, sui motivi del singolare affidamento ad Asciamprener della curatela dell’epistolario di Guido Gozzano da parte della Garzanti, e il critico Franco Contorbia, che ne ha elencato le stroncature5, ha ipotizzato un rapporto di forza dovuto al fatto che proprio il bibliofilo milanese possedesse le carte del letterato6. In sintesi, la notifica di un libro appartenuto a un collezionista, a questo punto, sembrerebbe essere un atto sempre culturalmente giustificabile dallo Stato, nonostante comporti, per il privato cittadino che ne è malauguratamente proprietario, una serie di limitazioni e obblighi pesanti.
Un clima di sospetto e le sue radici storiche
Tutto ciò non deve indurre il libraio alla polemica. Il caso è stato qui raccontato per illustrare un clima istituzionale sostanzialmente ostile al mercato, e indagarne le ragioni storiche. Questa rigidità strutturale, tradotta in pratica nell’uso primario dello strumento della notifica anziché della prelazione o dell’acquisto, spinge infatti a chiedersi se esista ancora in Italia un ruolo nobile per l’antiquariato librario, perché il rispetto delle regole, da noi più che altrove, costa carissimo, e chi esercita la professione legalmente ha un indubbio svantaggio competitivo. Va studiata, allora, la motivazione di certe incursioni dello Stato italiano sulla circolazione, nonché l’origine della legislazione della Repubblica, in particolare quella dei beni culturali sotto la quale ricadono i nostri amati libri antichi. E colpisce, consultando Andrea Emiliani7, che dopo l’Unità d’Italia i primi governi non abbiano formulato affatto una nuova politica di tutela, ma nel 1861 abbiano scelto di mantenere in vigore la più stringente e assolutistica tra le normative ereditate dagli Stati preunitari: quella pontificia.
Essa era stata varata nel lontano 1802 col Chirografo di Pio VII Chiaramonti e perfezionata nel 1820 col successivo regolamento redatto dal suo Camerlengo, il cardinale Giuseppe Pacca. Si trattava di una reazione istituzionale alle massicce spoliazioni avvenute durante la Rivoluzione francese, allo sradicamento di opere d’arte e di reperti archeologici sotto Napoleone Bonaparte e alle vendite all’asta delle preziose biblioteche religiose soppresse. Il fatto che Roma, in particolare, si fosse trasformata tra il XVIII e il XIX secolo in un inesauribile bacino per il collezionismo predatorio europeo, che riforniva sia i viaggiatori del Grand Tour sia i musei d’oltralpe, aveva sconvolto il Papa e dato vita alla legislazione più severa al mondo. Con queste ferite al patrimonio culturale, nostro malgrado, ci si convinse che l’interesse pubblico fosse incompatibile con la libera circolazione delle opere. Anni dopo, lo Stato italiano ereditò questo stile emergenziale, applicando la medesima legge per quasi mezzo secolo, reputata allora la più cogente e moderna, persino emulata da altri paesi europei.
L’eredità di una visione statalista
Anche le successive leggi italiane sul patrimonio culturale, dal XX secolo agli inizi del XXI, hanno mantenuto un approccio di tutela impositivo e proibitivo, richiamando la stessa logica ottocentesca. La prima legge nazionale dell’Italia unita fu varata soltanto nel 1902 (Legge Nasi), e fu perfezionata e resa onnicomprensiva nel 1909 (Legge Rosadi-Rava) sotto il governo di Giovanni Giolitti, estendendo nel quadro della normativa il concetto stesso di bene culturale. Indipendentemente dal suo grado di praticabilità, la severa impostazione rimase invariata e, se possibile, si inasprì ulteriormente nella legge del 1939 voluta da Giuseppe Bottai durante il regime fascista. Infine, la sua eco si è riversata con inalterata duttilità anche nel Codice dei beni culturali e del paesaggio noto come Codice Urbani8, approvato nel 2004 durante il governo di Silvio Berlusconi.
Dobbiamo riconoscere che questa struttura normativa, coerentemente statalista e centralista – che attribuisce allo Stato il monopolio della tutela e guarda al mercato con pregiudizio e diffidenza – ha avuto un certo ruolo educativo sulla coscienza culturale dei cittadini italiani, forgiando una percezione del patrimonio culturale come un bene di tutti, sacro e intoccabile, che molti paesi stranieri ci invidiano. Tuttavia, il perdurare di questi ideali ottocenteschi ha posto le istituzioni in costante clima di sospetto nei confronti dei librai antiquari – ma anche, ovviamente, antiquari tout court e mercanti d’arte – creando un divario palpabile e deleterio per il patrimonio stesso. Perché all’estero, principalmente nei paesi di tradizione anglosassone, lo Stato corteggia librai e collezionisti, considerandoli partner preziosi nella formazione di biblioteche, mentre in Italia accade l’opposto? Perché il libraio italiano deve temere una notifica anziché sperare in una collaborazione con prelazione e acquisto da parte delle biblioteche?
Chiariamoci: «L’Italia è stata fino a qualche decennio fa un paese meravigliosamente conservato in quanto ancora arretrato»9, non certo per merito dell’efficacia e del dinamismo di una politica di valorizzazione, specialmente se intesa nel quadro di un armonioso rapporto tra pubblico e privato. Il mercato, se riconosciuto nel suo ruolo, avrebbe potuto viceversa contribuire ad accrescere e promuovere questo tesoro bibliografico. È quindi il momento di auspicare un correttivo partecipativo per l’epoca che viviamo, abbandonando le fantasticherie su un passato diverso.
Verso una collaborazione a vantaggio di tutti
Come possiamo migliorare le cose? Può la categoria dei librai antiquari contribuire alla tutela del patrimonio? Non è una pretesa insensata. Voglio citare alcuni esempi recenti che, nonostante gli ostacoli e le improvvise frenate, possono essere interpretati come segnali di fiducia reciproca tra istituzioni e mercato, e che, incrociando le dita, potrebbero anticipare un indirizzo maggiormente inclusivo.
Il primo caso risale allo scorso inverno. Il nostro «sindacato» – così Alberto Vigevani definiva l’Associazione Librai Antiquari d’Italia (ALAI)10 – ha preso parte ogni due settimane alle riunioni del Dipartimento Tutela del Ministero della Cultura per la revisione del decreto che fissa le modalità per la circolazione internazionale dei beni culturali11. L’ALAI, infatti, è stata formalmente coinvolta in questo gruppo di lavoro istituzionale, composto dalla Direzione Belle Arti, Direzione Archivi, Direzione Biblioteche, Ufficio legislativo del Ministero della Cultura e anche dagli amici del Gruppo Apollo, portavoce degli stakeholder del mercato dell’arte12. Durante le numerose sedute, ALAI e Apollo hanno offerto un contributo all’analisi dettagliata degli articoli e dei commi del decreto, oltre che ai pareri dell’Avvocatura dello Stato, con un’attitudine partecipativa agli indirizzi di tutela. A mio giudizio, si è creata un’atmosfera di sincera collaborazione e, parafrasando Camillo Boito, un interessante equilibrio tra le doverose necessità del passato e i diritti del futuro13. In particolare, ci si è soffermati sull’intento di semplificazione da cui nasceva il decreto, accordandosi per renderlo più efficace secondo le necessità di modifica espresse dal Ministero stesso. Mentre scrivo il documento conclusivo è ancora in fase di valutazione, ma ciò che preme registrare è il fatto che sia stata possibile una convergenza tra il Ministero e le categorie, inaugurando un clima ideale da perseguire. Inoltre, gli stessi rapporti tra ALAI e Apollo si sono decisamente intensificati, impegnandoci a un futuro lavoro di squadra sui punti in comune.
Il secondo caso, invece, riguarda la specifica attenzione che nella riorganizzazione del Ministero della Cultura godranno in futuro i beni librari e archivistici, e il contributo che la nostra categoria vi potrebbe apportare. Nelle interlocuzioni tra ALAI e Ministero è emersa infatti l’esigenza di intervenire su alcune criticità relative al rilascio dei documenti per la circolazione internazionale dei libri, che a livello pratico soffrono la burocrazia più degli altri beni culturali, sovraccaricando di lavoro il personale amministrativo. La Direzione Generale Biblioteche ha così preso in considerazione una nota di ALAI sulle buone pratiche da auspicarsi presso i nuovi Uffici Esportazione che verranno creati sul territorio nazionale. A tal proposito, anche in considerazione del recente decreto che trasferisce la competenza sul rilascio dei permessi di esportazione dei libri antichi alle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche anziché alle Belle Arti14, si è successivamente riunito il Comitato tecnico scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali, esaminando l’argomento. È un segnale di democrazia il fatto che l’istanza di un’organizzazione come la nostra, che ha da sempre l’obiettivo di disciplinare e migliorare il commercio del libro antico, raro e d’occasione, operando a stretto contatto con le principali istituzioni preposte alla salvaguardia del patrimonio nazionale, sia vagliata come possibile orientamento sul tema. Meliora speramus.
Il ruolo del libraio antiquario
Nell’eventualità in cui nei paragrafi precedenti abbia urtato qualche suscettibilità, dichiaro comunque che quanto scritto non vuole essere una speculazione teorica. Noi librai antiquari, anche con incarichi associativi di responsabilità, nei fatti lasciamo ai bibliotecari e ai funzionari ministeriali il ruolo di teorici e specialisti della tutela. Esiste la figura del soprintendente; noi siamo, in fondo, operatori commerciali. Le nostre riflessioni non sono frutto di uno studio spassionato, noi siamo la controparte privata e sinceramente leghiamo la nostra politica agli affari. Vogliamo vendere. Tuttavia, in un contesto moderno, riteniamo che questo commercio specialissimo non debba più configurarsi come peccato originale, malgrado – come si è visto – il pregiudizio sia radicato nella storia d’Italia, né giustificare alcun contrasto con la salvaguardia dei beni culturali. Il lettore converrà, infatti, che senza una categoria preparata e legittimata a nuovi ritrovamenti, nell’Italia moderna i libri rari non verrebbero più rintracciati, studiati, collezionati e proposti con professionalità alle istituzioni. La cultura ne soffrirebbe irrimediabilmente, poiché un mercato ben regolamentato non è mai risultato né inutile né dannoso al patrimonio.
Lo ha dimostrato con semplicità la bibliotecaria Stephanie Stillo, capo dipartimento libri rari alla Library of Congress di Washington, grazie a un intervento di grande intensità presentato al congresso di Amsterdam della Lega Internazionale dei Librai Antiquari (LILA-ILAB) dell’Ottobre 2024, che vorrei ora riportare15. «La catalogazione commerciale – ha detto – è il primo contatto formale dei bibliotecari con i libri presenti sul mercato e la base per giustificarne l’acquisto. I cataloghi antiquari vengono studiati, archiviati e utilizzati attivamente per la ricerca, proprio come i librai usano viceversa i metadati delle biblioteche. In questo senso, le istituzioni dipendono dall’accuratezza e dalla diligenza del commercio». Poco dopo ha continuato, con parole che traduco liberamente dall’Inglese: «I librai fungono da collegamento tra un collezionista che intende donare o vendere la propria raccolta e il sistema bibliotecario. Le grandi istituzioni spesso non hanno la capacità di costruire quei rapporti personali di fiducia che richiedono anni di investimento finanziario e umano tra un commerciante e un collezionista. A conti fatti, le biblioteche traggono molto beneficio dalle relazioni che nascono nelle librerie antiquarie». Infine, altrettanto significativamente, ha aggiunto: «Le associazioni di categoria nazionali sono viste dalla Library of Congress come un baluardo contro i furti nel mondo del collezionismo, e le migliori istituzioni iniziano anche a fare uso del Missing Books Register, il recente portale ideato dalla Lega Internazionale dei Librai Antiquari che elenca i libri scomparsi di cui si conoscono gli estremi16. Questo strumento è abbondantemente promosso tra le biblioteche affiliate alla International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), ed è così che i curatori si avvalgono delle conoscenze del mercato pure nel settore della sicurezza».
Insomma, per non dilungarmi oltre, posso concludere che per Stephanie Stillo le funzioni fondamentali svolte dalle librerie antiquarie per le biblioteche sono di sicuro tre: innanzitutto «Memory» (fonte d’informazioni); quindi «Matchmaker» (collegamento coi possessori); infine «Monitor» (argine all’illegalità). Si tratta di una triade chiara a cui attenersi per difendere la bontà del nostro mestiere e nasce, più che da un ragionamento, dall’esperienza spiazzante di un dipendente pubblico statunitense. Non ci sono dubbi: l’attribuzione di questi compiti incoraggia il nostro impegno professionale e dà un senso intrinseco al nostro lavoro quotidiano, per altro in epoche in cui, purtroppo, recuperi trionfali come quello della Bibbia di Borso d’Este da parte del collega Tammaro De Marinis sono ormai un miraggio17. Pensandola proprio così l'antiquariato librario, che è un anello indispensabile perché la catena de beni culturali funzioni davvero, sarà finalmente riconosciuto anche in Italia come fattore di bene comune. Ripartirei allora da qui per rinnovare, ad ogni stagione, la nostra antica proposta di collaborazione con le istituzioni.
Note
1 LEO S. OLSCHKI, La persecuzione doganale dei libri in Italia, in «La Bibliofilía», Vol. 7, No. 5/7 (Agosto-Settembre-Ottobre 1905), pp. 129-138.
2 Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta, Decreto n.18 del 23 Ottobre 2019.
3 CARLO ALBERTO CHIESA, «Un mestiere semplice». Ricordi di un libraio antiquario, Milano, Officina Libraria, 2016, pp. 41-45.
4 CESARINO BRANDUANI, Memorie di un libraio, Milano, Longanesi, 1964, pp. 168-169.
5 GUIDO GOZZANO - AMALIA GUGLIELMINETTI, Lettere d’amore, a cura di Franco Contorbia, Macerata, Quodlibet 2019, pp. 211-226.
6 CLAUDIA BRUNOTTI, ‹‹Fruscìo di seta››. Amalia Guglielminetti poetessa (e la corrispondenza con Gozzano), Tesi di Laurea, Dipartimento di Filologia, Letteratura, Linguistica dell’Università di Pisa, relatore prof. Giorgio Masi, a. a. 2012-2013, p. 59.
7 ANDREA EMILIANI, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani, Firenze, Edizioni Polistampa 2015.
8 D.Lgs. 42/2004.
9 ANDREA EMILIANI, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani, op. cit., p. XV.
10 ALBERTO VIGEVANI, La febbre dei libri. Memorie di un libraio bibliofilo, Palermo, Sellerio Editore, 2000, p. 40.
11 DM 246/2018.
12 L’Associazione Gruppo Apollo è la confederazione italiana che riunisce le associazioni di categoria che ruotano attorno al mondo dell’arte; persegue la finalità di monitorare e sostenere la filiera dell’arte e dei beni di interesse culturale.
13 CAMILLO BOITO, Questioni pratiche di Belle Arti, Milano, Ulrico Hoepli 1893, pp. 67-85.
14 DPCM 57/2024.
15 ILAB Presidents’ forum in Amsterdam, The Netherlands, 14 Oct. 2024, Session 3: Fostering Stronger Ties. Collaboration between the Rare Book Trade and Special Collections Libraries.
16 Cfr. la pagina web https://missingbooksregister.org.
17 Cfr. MARTINA BAGNOLI, Tammaro De Marinis e la Bibbia di Borso d’Este. Cronaca di un trionfale recupero, in «Multa renascentur». Tammaro De Marinis studioso, bibliofilo, antiquario, collezionista, Venezia, Marsilio Editori, 2023, pp. 67-75.